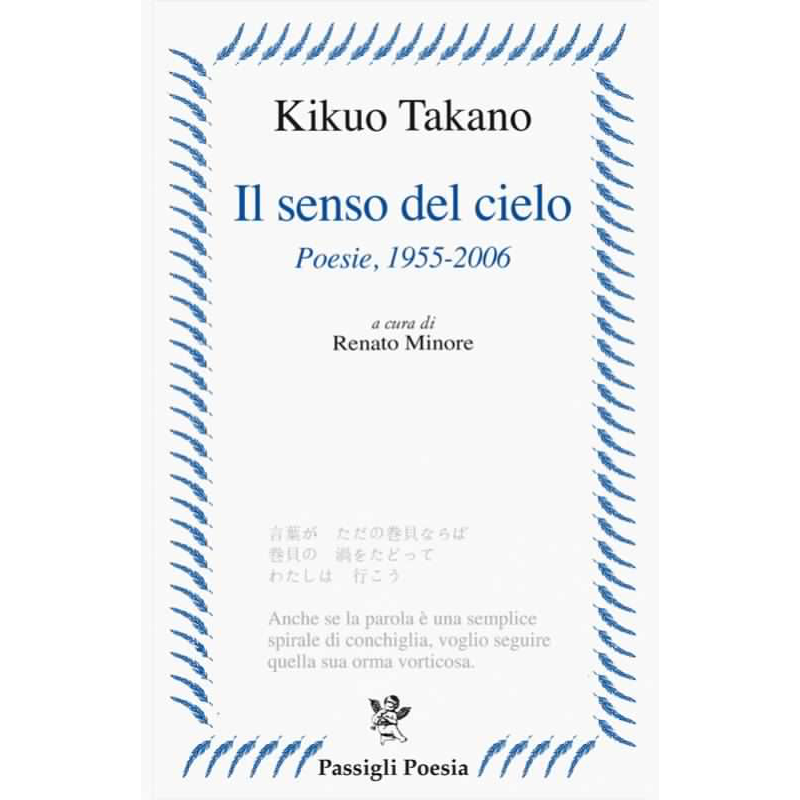ESSERE NEL NAUFRAGIO
La prima cosa da fare, credo, ragionando intorno alle poesie di Kikuo Takano, è difenderle contro una lettura banalmente “poetica”: il vuoto, lo smarrimento dell’anima, il miracolo della natura (“rabbrividiscono i fiori di mimosa”), l’amore per la vita – genericità che potrebbero richiamare, soddisfacendo le nostre basse voglie di sublime, certo ermetismo attardato di provincia. La sua poesia è invece per eccellenza drammatica e antisentimentale, violenta asimmetrica esigente; una poesia che non ha paura di riconoscersi contraddittoria, di tacere quando è il caso, e che non cerca il facile plauso. Non per niente nasce, storicamente, dal disastro del Giappone post-bellico; Takano ricorda, lui diciottenne, l’incontro in treno con una sopravvissuta di Hiroshima. La poesia si riconosce spezzata come è in quel momento il Paese, La sintassi è squassata, il metro (per quanto si può capire dalle traduzioni, e posto che il paradigma di linearità che vige laggiù sia confrontabile al nostro) si disarticola in membri brevissimi e lunghissimi, il verso libero e contundente si impone come esigenza psicologica; “Arechi”, il nome della rivista che ospita le sue prime prove mature, in giapponese significa letteralmente “deserto”, “terra desolata”. Aridità, desolazione, frammentazione sono prima di tutto dei dati fisici, creaturali – per salvarsene esprimendoli l’unica via è quella della cultura, che per Takano è fin dall’inizio una cultura razionale, lucida, di matrice filosofica e scientifica (mai dimenticare che è stato un buon matematico, autore di importanti ricerche sulla formula del pi greco).
Takano legge Heidegger, che già per suo conto si era interessato allo zen; poi legge Jaspers, in un testo cita Merleau-Ponty. Esistenzialismo e fenomenologia occidentali lo rafforzano nell’idea di distinguere l’Essere dall’esistere: sotto (o sopra) la vita di tutti i giorni c’è un Fondamento non visibile che dà senso al visibile (e che talvolta si può chiamare Dio). Ma il Fondamento è assenza, vuoto; il segreto profondo dell’Essere è il Nulla. La sua educazione orientale dà a questa meditazione filosofica un colore e un calore, insomma una serenità, che noi non sappiamo concederci quando pensiamo al nichilismo o al silenzio di Dio. In un’intervista Takano definisce lo zen “una modalità di attesa molto fervida per rinunciare a se stessi”. Il vuoto è apertura, possibilità di uno sguardo che va oltre, liberazione dalla prigione dell’io; l’uomo è l’Interrogante per definizione, “appeso a un gancio dove non c’è nulla da appendere”. La domanda è forse la figura retorica dominante nei suoi testi, fitti di punti interrogativi – l’uomo consiste solo se moltiplica le proprie incertezze, come la trottola sta in piedi solo finché gira. Ma questa intuizione (e allegria) metafisica non libera affatto Takano dalla disperazione personale: il vuoto che è radice dell’essere, come nella fuga senza fine di due specchi affrontati, è omologo alla solitudine, alla distanza inesorabile che separa le persone.
Sempre (tranne forse in alcune pacificate poesie della vecchiaia) nel mondo di Takano gli amanti non comprendono il loro legame che nell’istante in cui si separano: “se la gente s’abbraccia si moltiplicano le solitudini, e dall’abbraccio nasce una nuova solitudine”. Dall’incontro scaturisce l’addio, perché le domande dell’uno divergono da quelle dell’altra: “mai ci siamo abbracciati, perché/ eravamo per noi stessi un labirinto”; tra le persone diventa difficile anche dire “scusami”, l’incomprensione è più seria del malinteso caratteriale, avvicinandosi a uno spaesamento più sociale che psicologico (da noi negli anni Sessanta la si chiamava “alienazione”). Takano in questo è severo, esige che la coscienza dell’isolamento singolare sia bevuta fino alla feccia: “possa cadere fino in fondo/ quello che cade” (altrove, con più cinico disincanto, “ognuno viva il proprio inferno”). Anche da noi l’esistenzialismo ha portato a disperazioni analoghe, basta chiedere a Sartre. Quando nell’assoluta beata sospensione del vuoto zen (“né fuori né dentro al cerchio dell’essere, ma proprio sopra la sua circonferenza”) si inserisce quella “bestia ostinata e affamata” che è il desiderio, allora scatta il dolore. La solitudine è cercata e odiata allo stesso tempo, l’individuo è scisso in parti contraddittorie: “io sono le molle roventi/ e la mano che le stringe” (come non pensare a Baudelaire, “je suis la plaie et le couteau” ?).
A consolare giunge un concetto tipicamente buddhista, la compassione per la sofferenza universale: per l’uomo sulla spiaggia che raccoglie rifiuti, per la ragazza che ha vissuto “come se fosse la gomma per cancellare se stessa”, per gli animali le piante le cose – l’astratto ha bisogno degli uomini per non annoiarsi eternamente: “il cielo è venuto sulla terra/ per covare se stesso/ furtivamente, a tal punto/ non ne poteva più”. Se il desiderio tende a possedere le cose, la salvezza consiste nel diventare le cose invece di possederle; l’amore di Takano per la natura non ha niente di superficialmente elegiaco o, peggio, paesaggistico – è l’immersione, l’identificazione piena del proprio essere con l’essere dell’acqua, delle nuvole, delle foglie; una foglia di loto è “una mano meravigliosa/ su cui l’acqua incontra/ se stessa per la prima volta, s’accorge/ del proprio vero volto e ritorna/ alla sua luce vera”. Tutta la natura è dotata di un’anima: la pietra, essendo stata stella in origine, anela a tornare in cielo e in questa folle tensione si trasforma in bosco. (Qui sta l’amore di Takano per l’Abruzzo, dal Giappone super-industriale alla foresta selvatica, in una specie di esotismo rovesciato).
Ma, dicevo, Takano è troppo intellettuale per non fare anche della natura un simbolo; nascono allora, e sono tratti caratteristici del suo scrivere, quelle metafore distese, o meglio quei “correlativi oggettivi” (qui conta la sua appassionata lettura di Eliot, nonché di Montale) che incoronano al centro di un testo il disco, la corda, la girandola, o il fiore di loto, o il ragno, o il cigno, per farli diventare emblemi del modo di esistere su questa terra. Chiedere aiuto a tutti gli esseri per spiegare il terribile mistero dell’Essere. Perché, e su questo davvero si conclude l’avventura umana e poetica di Takano, il mezzo più alto per dare senso a se stessi e non perdersi nella disperazione è la Parola. La Parola non è che una “spirale di conchiglia” sonante del proprio vuoto, ma “nella parola c’è la via” (cioè il Tao). La parola è divina mediatrice, è musica e la musica tiene l’universo in equilibrio (molti testi di Takano sono stati musicati, e alcuni nascono addirittura come parole per musica). L’ammirevole sobrietà di Takano, il suo rigore stilistico, il suo spogliarsi di abbellimenti o acrobazie verbali inutili è del tutto coerente con la ricerca di autenticità (bisogna “sbucciarsi l’anima come il gambo dell’erba cipollina”). C’è il magistero dei tanka e degli haiku (in un testo cita con venerazione Bashō), sia pure intinti in un’angoscia tutta moderna. La depressione lo porta a sospettare l’impotenza creativa (“non possiedo/ neppure le parole che dico”), ma proprio questo non possedere segnala la forza a noi estranea della Parola. “Cosa è stata la parola per noi ?”, si chiede in una riflessione metaletteraria, e si risponde parafrasando John Kennedy “chiediamoci cosa possiamo essere noi per la parola”.
L’utilità maggiore di rileggere oggi Takano, se vogliamo per un attimo riflettere in termini di politica culturale, è proprio ricordarci la centralità della parola, e la necessità del profondo, in un’epoca in cui il rumore si è fatto assordante (tanto che lo stile non sembra più essere percepito) e in cui tutto sembra affermarsi in estensione, per pura forza di orizzontalità.
Walter Siti